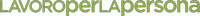COLTIVARE L’UMANO NELL’ECONOMIA E NEL LAVORO
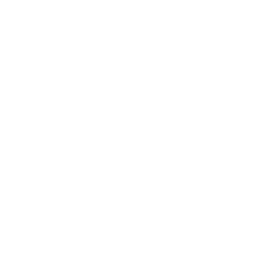
ATTIVITÀ
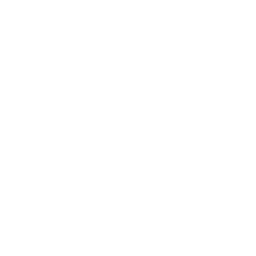
PUBBLICAZIONI
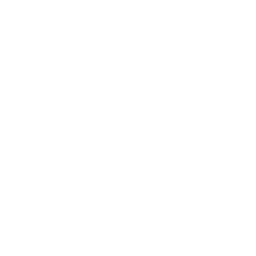
SOSTIENICI
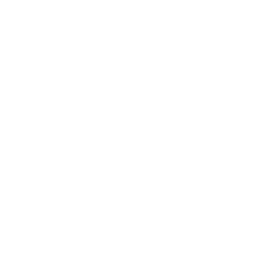
CONTATTI

FAR FIORIRE L'UMANO NELL'ECONOMIA E NEL LAVORO
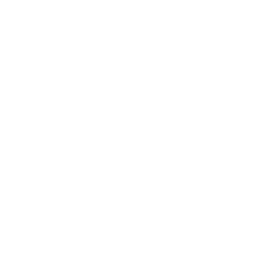
ATTIVITÀ
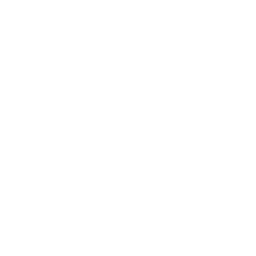
PUBBLICAZIONI
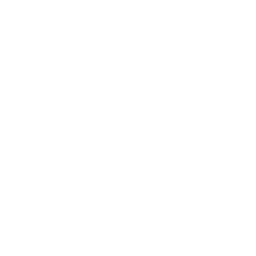
SOSTIENICI
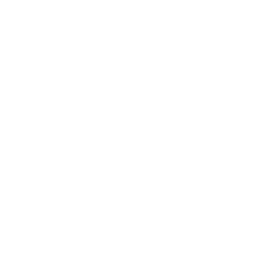
CONTATTI
agenda
#EllePì Rosora - Appunti di un viaggio sul senso del lavoro
Si è svolto lo scorso sabato 29 novembre al Teatro Comunale di Poggio San Marcello un evento originale e significativo promosso dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS in collaborazione con il giornale Voce della Vallesina. L'occasione ha visto la presentazione e la riflessione sul volume "Appunti di viaggio. Coltivare l’umano nell’economia e nel lavoro", una raccolta di contributi frutto di anni di riflessioni, precedentemente pubblicate sulle pagine del settimanale locale.
Il libro, è un prezioso contributo per orientarsi nelle sfide del presente, ed è una riflessione corale che tocca temi cari alla Fondazione come: Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e, naturalmente, il Senso del lavoro. L'iniziativa ha voluto superare la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di autentico dialogo intergenerazionale. Per questo motivo, il testo è stato consegnato ai primi cittadini del territorio - senior e junior - per raccogliere le loro testimonianze e riflessioni.
L'evento, iniziato dopo i saluti di Fabrizio Chiappa, sindaco di Poggio San Marcello, del Presidente della Fondazione, Gabriele Gabrielli, con la partecipazione di Beatrice Testadiferro, Direttrice di Voce della Vallesina, e la moderazione di Michele Cardinali, collaboratore della Fondazione e docente di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Macerata, ha visto una partecipazione d'eccezione. Amministratori e cittadini si sono disposti in un grande cerchio per intavolare una riflessione condivisa sui temi centrali tratti dal volume. Ospiti dell’evento: Giuseppe Montesi (Sindaco di Castelplanio), Nico Consoli (Assessore di Castelplanio), Sebastiano Mazzarini (Vicesindaco di Maiolati Spontini), Luca Possanzini (Sindaco di Mergo), Paolo Bernardini (Vicesindaco di Rosora) e Alessandra Ceccucci (Consigliera di Rosora). Insieme a loro, hanno dialogato tre giovani mini sindaci: Enea (Poggio San Marcello), Riccardo (Mergo) e Alice (Maiolati Spontini). Il dibattito ha toccato argomenti cruciali come il lavoro e il suo senso, economia, vocazioni, pregiudizi intergenerazionali e molto altro ancora.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, inclusi i cittadini del territorio, che hanno preso parte all’evento e che sono usciti dalla splendida sala del teatro con l’energia della speranza. L’incontro si è concluso con un interrogativo aperto, che suona come un impegno per il futuro: come rendere stabile e continuativo questo dialogo intergenerazionale per farlo diventare il format educativo e di cittadinanza attiva di questo territorio? L'evento ha confermato lo stretto rapporto tra la Fondazione Lavoroperlapersona ETS e Voce della Vallesina, riaffermando l'importanza di stimolare la riflessione pubblica sul senso profondo del lavoro.
Webinar EllePì - Costruire la parità di genere nel lavoro
Costruire la parità di genere nel lavoroQuali i passi già fatti e quanta strada ancora da fare? giovedì 20 novembre - ore 18:00
Una mattina come tante, Ludovica accompagna il figlio all’asilo e la figlia a scuola; torna a casa, finisce di sistemare la cucina e accende il pc alle 9. Un’ora dopo squilla il telefono; è la maestra dell’asilo: suo figlio sta male. Ludovica va a prenderlo, lo porta a casa e ricomincia a lavorare. Risponde a qualche mail e di tanto in tanto va a vedere come sta, cercando di dividersi come meglio può. Ed ecco che un duplice senso di colpa si fa avanti: si sente una lavoratrice non totalmente concentrata e improduttiva, e si sente una madre non abbastanza attenta e di supporto per il figlio. Eppure, Ludovica sta mettendo anima e cuore in entrambi i mondi.
Ludovica è una donna che ha scelto di raccontare su Instagram le difficoltà di una quotidianità in cui i molteplici ruoli che ricopre, gli stessi ruoli che la rendono felice, la fanno sentire inadeguata. Questo racconto non rappresenta un caso individuale, ma una condizione collettiva: il modo in cui le donne abitano il mondo del lavoro conosce sfide che chiedono di essere affrontate a livello sociale, non lasciate a gravare sulla sfera personale. Secondo una stima del World Economic Forum, mantenendo l’andamento attuale, a livello globale sarebbero necessari circa 135 anni per raggiungere la piena parità di genere nel mercato del lavoro[1].
Tra le quattro dimensioni incluse dal World Economic Forum nell’indice globale di divario di genere, la “partecipazione all’economia e opportunità” è una delle aree in cui sono stati fatti maggiori progressi verso la parità di genere; tuttavia, è ancora uno degli ambiti dove il divario è tra i maggiori (il sottoindice relativo è pari al 61%, dove il 100% rappresenta la parità di genere). Se il sottoindice globale relativo al livello di istruzione sta raggiungendo buoni livelli, non sempre l’accesso al sistema educativo si traduce in un ingresso o in una permanenza equi nel mercato del lavoro. Nella classifica mondiale, l’Italia si trova al 117° posto, con un sottoindice di partecipazione all’economia e opportunità pari a 0,599 (dove 1 rappresenta la parità di genere)[2].
Le principali aree critiche sono:
il tasso di occupazione femminile, che “nel (…) 2024 risulta inferiore di 12,6 punti alla media UE (…), rimanendo il valore più basso tra i ventisette paesi dell’Unione europea”[3];
il divario retributivo per lavori a parità di mansioni e qualifiche. Particolarmente importante è la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva[4], che consente di chiedere al datore di lavoro i livelli retributivi medi classificati per genere delle categorie che svolgono lavori di pari valore e i criteri utilizzati per determinare la progressione della retribuzione;
la stabilità occupazionale (frequente è l’utilizzo di contratti precari e part-time involontari, nonché l’interruzione lavorativa);
le opportunità di avanzamento di carriera e di accesso a posizioni di leadership.
La mattinata di Ludovica è un esempio semplice ma emblematico di come la parità di genere sia una tematica che abbraccia tutte le sfere della vita e dell’identità delle donne, poiché la complessità delle casistiche quotidiane richiede di attraversare dinamicamente la “barriera” tra vita personale e lavoro, bilanciando responsabilità ed energie.
In questo quadro, come il sistema culturale impatta sulla costruzione di un ambiente più o meno equo? Come il ruolo sociale delle donne incide sulle modalità di gestione del loro tempo? Quali sono i settori, le funzioni e i ruoli dove il divario di genere è maggiore e perché? Il divario ha un peso diverso a seconda della fascia di reddito? Quali sono gli ostacoli invisibili che influenzano la vita lavorativa di una donna? Quali strumenti, sia a livello sociale sia organizzativo, agevolano concretamente la parità di genere e quali interventi hanno uno scarso impatto oltre la superficie? È importante considerare che l’obiettivo della parità di genere nel lavoro, che trova fondamento nell’articolo 37 della Costituzione italiana, ha una forte rilevanza sia sociale sia economica: promuoverla “potrebbe stabilizzare il rapporto occupazione/popolazione nella maggior parte dei paesi dell’OCSE”[5].
Non si tratta di una meta da raggiungere, ma di un obiettivo da costruire e ricostruire costantemente in relazione all’evoluzione del contesto economico-sociale nel corso del tempo e nelle diverse geografie. La mappa che può fungere da guida in questo percorso va tracciata man mano, seguendo due indicazioni imprescindibili segnalate dall’OIL: “analizzare e affrontare (…) le specifiche esigenze di donne e uomini e promuovere interventi mirati per consentire loro di partecipare in egual misura al mercato del lavoro”[6]; occorre partire dall’analisi dei bisogni per giungere alla progettazione di soluzioni rispondenti alle necessità intercettate.
[1] La stima si basa su una proiezione dell’incremento percentuale dell’Economic Participation and Opportunity Gap registrato dal 2006 al 2025.Global Gender Gap Report 2025, insight report, giugno 2025, World Economic Forum.[2] Global Gender Gap Report 2025, insight report, giugno 2025, World Economic Forum.[3] Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità, documento di sintesi, 6 marzo 2025, CNEL-ISTAT.[4] Direttiva UE 2023/970[5] Prospettive dell’occupazione OCSE 2025: Italia, 2025, OECD.[6] Parità di genere nel mondo del lavoro, n.d., Organizzazione Internazionale del Lavoro. https://www.ilo.org/it/aree-tematiche/parita-di-genere-nel-mondo-del-lavoro
PARTECIPA AL WEBINARCOMPILANDO IL FORM SOTTOSTANTE!
[contact-form-7 id="c3918ca" title="Webinar EllePì - Parità di genere"]
Luigi Alici, la Speranza tra teologia e storia: "Una Virtù Sovversiva"
La speranza cristiana non nasce dalla mera antropologia del desiderio umano, ma è una risposta che scaturisce da una teologia della grazia; per questo, non è un sentimento che si fonda su un bisogno o una domanda, ma su una verità che è inconciliabile con qualsiasi forma di egemonia dogmatica. La speranza cristiana, dunque, non può rivendicare uno spazio privilegiato nella scena pubblica, proprio perché essa è una verità che vive nell'orizzonte del "non ancora", un luogo dove l'uomo è chiamato a rispondere a un bene che già lo sovrasta. Ma come si può trasmettere questa speranza nel mondo laico? Come possiamo darle un passaggio nelle nostre esistenze quotidiane? La via potrebbe trovarsi nel dialogo tra la speranza cristiana e quella sociale, entrambe accomunate dal destino comune dell'umanità: la strada su cui insieme si cammina continuando a domandarsi e a domandare. Questi i temi della lectio di Luigi Alici - professore emerito di Filosofia Morale presso l'Università di Macerata - che ha aperto l'ultima giornata del Film Festival Offida 2025.
Il disincanto della speranza
Oggi, la speranza sembra essere una parola svuotata di significato. Poche persone sono in grado di nutrire speranze in grado di turbare l’ordine stabilito. La speranza è diventata una speranza moralistica, addomesticata e banalizzata, incapace di sfidare la realtà e di promettere una salvezza totale, ,e allora cosa possiamo fare di una speranza che non disturba e che non sembra più capace di mutare nulla? Per Alici è come se vivessimo una speranza "senza aspettative", che si riduce a un immobilismo privo di futuro. In fondo, il nostro rapporto con la speranza assomiglia molto a quello di un condannato a morte che ha la possibilità di scegliere l'ultimo pasto: una speranza che non cambia nulla, che ci lascia ancorati a un presente senza un vero orizzonte.
Gabriel Marcel definisce la speranza come un "problema e mistero", un mistero che ci sfida a riconoscere l’eccedenza del bene di fronte al trionfo del male. Il professore spiega che quando vediamo il male prevalere, la speranza cristiana ha il dovere di insorgere: il riconoscimento che, pur di fronte alla sofferenza e alla morte, il bene non può essere annientato. La speranza cristiana, quindi, non è solo una virtù che si situa nel mezzo, come il coraggio o la giustizia, ma è una virtù che sovverte. È una speranza che non può mai peccare per eccesso, ma solo per difetto. È una speranza che ci spinge a guardare oltre, a non accontentarci di un'illusoria giustizia, ma a cercare una redenzione che non dipenda dal nostro potere.
La speranza cristiana, quindi, nasce dal disincanto, dalla consapevolezza della superiorità del bene di fronte al male. È una speranza che non promette facili soluzioni, ma che, al contrario, riconosce il rischio e l'incertezza dell’esistenza. San Paolo, come la sua discepola Tecla, parlava di una "grazia eccedente", di un amore che trascende le nostre fragilità e che nessuna forza può annullare. La speranza cristiana non nasce dal vuoto di un desiderio, ma da un bene che già esiste. Non è una speranza che si fonda su un futuro incerto, ma, come ha detto Alici "sulla certezza di un amore divino che non ci abbandona mai".
Questa speranza, tuttavia, avvisa Alici, non può esistere senza un contesto. La speranza è sempre una realtà relazionale: non può mai essere solo "Io", ma è sempre "noi". La speranza muore quando viene afflitta dalla "fase storica" ed escatologica che riduce l'orizzonte umano a unicamente temporale, limitando le possibilità dell'uomo a un destino che sembra già segnato. La nostra cultura, oggi, vive questo tipo di contraddizione: da un lato, l'autocensura politica che minaccia di farci dimenticare l'annuncio della resurrezione, dall'altro, la tendenza ad accettare una visione della vita che non considera più la morte come un passaggio, ma come un punto finale. Viviamo in un mondo che ha smesso di vedere la speranza come un'aspirazione verso qualcosa che va oltre il nostro presente.
La speranza e il "presentismo": tra il marxismo e la gnosi
Il "presentismo" è una delle tentazioni più forti del nostro tempo, quella di ridurre il tempo a un solo, eterno presente, come se l'eternità e la storia fossero in conflitto. Eppure, come sottolineano filosofi come Bauman, la speranza non può essere disincarnata dal contesto storico. In effetti, negli anni '60, quando sembravano finire le grandi ideologie e con esse la promessa di un futuro migliore, il tentativo di fermare il tempo post-bellico sembrava promettere un mondo migliore. Ma oggi ci ritroviamo in un contesto simile, anche se più desolato, dove la lotta per la libertà sembra essersi affievolita, e le organizzazioni che una volta portavano speranza sono ridotte a ombre di ciò che furono.
Un autore interessante da questo punto di vista è Ernst Bloch, che nel contesto del marxismo ha teorizzato una "speranza eretica". Bloch rifiuta la visione di Marx secondo cui la religione sarebbe l'oppio dei popoli, ma al contrario vede nel cristianesimo un'utopia che cammina con piedi umani. L’ontologia del "non ancora" è il luogo dove l’impossibile potrebbe realizzarsi. La speranza è, dunque, un atto di fede storica, che non guarda a un aldilà, ma che si radica nella realtà concreta e quotidiana. In questo, Bloch si fa interprete di una speranza che è sempre storica, che nasce nel tempo, nella lotta, e che non ha mai una fine definitiva. Ma come direbbe Simone Weil, "a noi non è concesso di avanzare in linea verticale, è nella storia che dobbiamo vivere il tirocinio della speranza". La speranza non si trova fuori dalla storia, ma in essa, nella libertà di scegliere, di lottare, di resistere.
La speranza come responsabilità sociale
La pandemia, infine, ha accentuato la divisione tra libertà individuali e responsabilità pubbliche, un conflitto che ha aperto la strada a un nuovo colonialismo tecnologico. I politici, invece di offrire speranza, sembrano incapaci di immaginare un futuro migliore, mentre le disuguaglianze crescono e la libertà sembra un'illusione. Ma la speranza non può essere solo una reazione a una condizione di ingiustizia: deve partire dal riconoscimento del bene e della persona, dal senso di responsabilità che nasce dalla nostra relazione con gli altri.
In questo senso, la speranza cristiana può anche essere vista come una risposta al senso di morte che sembra affliggere il nostro mondo. Come scrive Von Balthasar, la speranza cristiana inizia là dove non c'è più speranza, nel buio della morte, e si estende, trasformandosi in solidarietà, in una speranza che va prima di tutto a favore delle vittime, degli oppressi, di chi non ha voce. La speranza, dunque, chiude il professore Alici, "è una virtù sovversiva". "Non è mai banale, non è mai semplice, ma è sempre un segno di resistenza", continua. In un mondo che sembra sempre più disincantato e privo di visioni future, la speranza è la luce che non smette di brillare, anche nelle tenebre. È un respiro che dà vita a ogni persona, e la fiducia in essa è l'ossigeno che permette all'umanità di sopravvivere, di rialzarsi, di lottare. E forse, in questo dialogo tra fede e storia, tra speranza cristiana e speranza umana, si gioca una parte fondamentale del nostro destino.
Un gioco... da ragazzi
Sabato 25 ottobre, alle 17:00, palazzo Luminari di Rosora
Quanto può essere avvincente l’avventura di un viaggio insieme ai grandi della storia? Lasciarsi guidare dal sapere di uomini e donne che hanno raccontato il Senso del Lavoro?
È questa l’esperienza ludico-educativa che la Fondazione lavoroperlapersona ETS propone ai ragazzi e alle ragazze, per esplorare i significati e i sensi del lavoro, giocando con i protagonisti della scienza, della letteratura, dell’economia, della filosofia… Un momento per riflettere insieme sul passato e costruire un futuro dignitoso e sostenibile. Facendo appello alla storia, il gioco, in particolare tra individui di generazione differente, è sempre stato uno specchio del contesto sociale e culturale della comunità di riferimento, rivelandosi sia intrattenimento che preparazione alla vita adulta: passaggio di conoscenze, valori e partecipazione gioiosa, una "palestra di vita" per imparare la cooperazione, la condivisione, la negoziazione e il rispetto dell'altro.
Da dove nasce il progetto? Dalla volontà di rendere fruibile in una nuova veste, costruita per i più giovani, la pubblicazione edita dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS dal titolo “Appunti di viaggio sul senso del lavoro”, una raccolta di brevi articoli che testimoniano il dialogo aperto con il territorio e le sue comunità (Gabrielli 2025).
Un viaggio, quindi, che prevede l’utilizzo di strumenti ludici quali un cartellone di riferimento e due mazzi di carte. E proprio le carte rappresentano quel legame intergenerazionale, che favorisce la voglia di giocare con oggetti manipolabili dal sapore antico eppure così contemporanei. Sfide di abilità, giochi di parole e memoria condivisa… Così come il cartellone: il campo di gioco che è anche patrimonio, conoscenza comune.
L’appuntamento è per sabato 25 ottobre, alle 17:00, presso il palazzo Luminari di Rosora.
Webinar EllePì - Lavoro e cambiamento climatico: una prospettiva politico-legislativa
Abituati a pensare il cambiamento climatico esclusivamente come problema di natura ambientale, rischiamo di tralasciare le molteplici sfaccettature di una questione ben più ampia. La realtà, infatti, è che esso influenza, direttamente o indirettamente, tutte le forme dell’agire umano. L’attività lavorativa, in questo senso, sta subendo dei cambiamenti che possono causare disorientamento tanto a livello personale quanto sul piano politico-legislativo. Talvolta percepiti come rischi, talvolta come occasioni e opportunità, indagare attentamente gli impatti del cambiamento climatico sul mondo del lavoro si rivela, quindi, necessario: che l’argomento sia la trasformazione del mercato del lavoro o che sia il mutamento delle professionalità, delle condizioni di lavoro, delle tutele e della formazione dei lavoratori, emerge sempre più l’urgenza di una collaborazione tra persone, enti, aziende e decisori politici per ricomporre una bussola capace di orientarci in tempi incerti.
A proposito delle condizioni di lavoro, tema centrale e ampiamente trattato nello studio del Centro di Ricerca Ellepì curato da Paolo Bonini e Gabriele Gessini, è interessante osservare come il lungo corso legislativo italiano, dall’entrata in vigore della Costituzione fino ai giorni nostri, abbia spostato l’interpretazione e l’applicazione della sicurezza sul lavoro «da una visione reattiva […] (centrata sul danno) a una concezione preventiva e integrata (centrata sul benessere organizzativo)»[1]. Un mutamento paradigmatico che “veste” il significato della parola salute non solo dell’attenzione per l’incolumità del lavoratore, ma anche e soprattutto della cura del suo benessere psicologico e sociale tramite l’organizzazione di contesti lavorativi nei quali viene tutelata la sua personalità e che, oggi, trovano nella questione climatica un’ulteriore opportunità per ri-pensarsi: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, infatti, stima che, ogni anno, circa 23 milioni infortuni sul lavoro sono collegati alle temperature troppo elevate[2].
Al livello, invece, delle sollecitazioni per le trasformazioni del mercato e di settori produttivi in termini sostenibili, gli interrogativi sono molteplici: come farlo e con quale urgenza? Che ruolo hanno le politiche occupazionali nei processi di riconversione ecologica? Come poter strutturare una formazione sensibile alle necessità ambientali e del lavoro dignitoso e sicuro? Laddove il lessico e il vocabolario dell’industria e della politica si ampliano di nuove terminologie come “lavoro verde”, “industria 5.0”, “stress termico” e “co-benefici”, è bene, infatti, chiedersi se esse ci parlano delle possibili vie di uscita da una condizione di emergenza globale o se rischiano di diventare parole-trappola vuote di significato atte a riprodurre un sistema che di mutare non ha proprio intenzione.
In ultimo, ancora una volta è bene ricordare, per non disorientarci all’interno della generatività frenetica che scaturisce dal rapporto fra cambiamento climatico e lavoro e nella corsa urgente di trovare soluzioni adeguate che armonizzino necessità produttiva e cura dell’ambiente, la saggezza necessaria richiesta per porre la persona sempre al centro di ogni nostra azione: la tutela della sua dignità, libertà e capacità di agire e decidere. Ancor più, in questo caso specifico, della relazione che essa intrattiene con la Terra che la ospita, lavorandola e custodendola.
[1] Bonini P., Gessini G., Lavoro e cambiamento climatico. Una prospettiva politico-legislativa, Edizioni Lavoroperlapersona, 2025, p. 16.[2] Organizzazione Internazionale del Lavoro: https://unric.org/it/rapporto-oil-alte-temperature-sul-lavoro-implicazioni-per-la-salute-e-sicurezza/
PARTECIPA AL WEBINARCOMPILANDO IL FORM SOTTOSTANTE!
[contact-form-7 id="2c0751f" title="Webinar EllePì - Lavoro e cambiamento climatico"]
blog
Tombola Intergenerazionale 2025
Rosora, 20 dicembre
Offida, 22 dicembre
La Fondazione Lavoroperlapersona ETS, come ogni anno, presenta la sua versione di Tombola , il gioco delle feste che accomuna le generazioni! Giunta quest’anno alla sua settima edizione, la Tombola Intergenerazionale EllePì, nella cornice progettuale FuturoAnteriore, è un momento per incontrarsi, condividere, chiacchierare, riflettere di lavoro e non solo… giocando.
Chi gioca:
Le squadre “intergenerazionali” sono composte da due o più giocatori di età differente: nonni e nipoti oppure genitori e figli, oppure zii e nipoti. È fondamentale che siano diverse le generazioni presenti in ogni squadra.
Come si gioca:
Come ogni tombola che si rispetti, cartellone, cartelle e numeri sono gli strumenti del gioco. Ogni squadra può richiedere una o due cartelle per componente. Tra i 90 numeri sono inseriti anche i numeri “attivi”: ogni numero speciale prevede una attività o sfida o riflessione.
Chi vince:
Sono premiate: la terna, la quaterna, la cinquina, tombola e tombolino (la seconda tombola).
Gli appuntamenti per la Tombola Intergenerazionale 2025:
sabato 20 dicembre al Palazzo Luminari di Rosora, alle 17:00
lunedì 22 dicembre nella chiesa di San Michele, ad Offida, alle 16:30.
Per iscrivere la propria squadra, basta compilare il modulo qui sotto
[contact-form-7 id="bdff202" title="Iscrizione Tombola Intergenerazionale 2025"]
#EllePì Rosora - Appunti di un viaggio sul senso del lavoro
Si è svolto lo scorso sabato 29 novembre al Teatro Comunale di Poggio San Marcello un evento originale e significativo promosso dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS in collaborazione con il giornale Voce della Vallesina. L'occasione ha visto la presentazione e la riflessione sul volume "Appunti di viaggio. Coltivare l’umano nell’economia e nel lavoro", una raccolta di contributi frutto di anni di riflessioni, precedentemente pubblicate sulle pagine del settimanale locale.
Il libro, è un prezioso contributo per orientarsi nelle sfide del presente, ed è una riflessione corale che tocca temi cari alla Fondazione come: Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e, naturalmente, il Senso del lavoro. L'iniziativa ha voluto superare la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di autentico dialogo intergenerazionale. Per questo motivo, il testo è stato consegnato ai primi cittadini del territorio - senior e junior - per raccogliere le loro testimonianze e riflessioni.
L'evento, iniziato dopo i saluti di Fabrizio Chiappa, sindaco di Poggio San Marcello, del Presidente della Fondazione, Gabriele Gabrielli, con la partecipazione di Beatrice Testadiferro, Direttrice di Voce della Vallesina, e la moderazione di Michele Cardinali, collaboratore della Fondazione e docente di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Macerata, ha visto una partecipazione d'eccezione. Amministratori e cittadini si sono disposti in un grande cerchio per intavolare una riflessione condivisa sui temi centrali tratti dal volume. Ospiti dell’evento: Giuseppe Montesi (Sindaco di Castelplanio), Nico Consoli (Assessore di Castelplanio), Sebastiano Mazzarini (Vicesindaco di Maiolati Spontini), Luca Possanzini (Sindaco di Mergo), Paolo Bernardini (Vicesindaco di Rosora) e Alessandra Ceccucci (Consigliera di Rosora). Insieme a loro, hanno dialogato tre giovani mini sindaci: Enea (Poggio San Marcello), Riccardo (Mergo) e Alice (Maiolati Spontini). Il dibattito ha toccato argomenti cruciali come il lavoro e il suo senso, economia, vocazioni, pregiudizi intergenerazionali e molto altro ancora.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, inclusi i cittadini del territorio, che hanno preso parte all’evento e che sono usciti dalla splendida sala del teatro con l’energia della speranza. L’incontro si è concluso con un interrogativo aperto, che suona come un impegno per il futuro: come rendere stabile e continuativo questo dialogo intergenerazionale per farlo diventare il format educativo e di cittadinanza attiva di questo territorio? L'evento ha confermato lo stretto rapporto tra la Fondazione Lavoroperlapersona ETS e Voce della Vallesina, riaffermando l'importanza di stimolare la riflessione pubblica sul senso profondo del lavoro.
#Reportage EllePì - Violenza - Capitolo 1 parte 1
Che si associ l’atto di cura ad una precisa e determinata figura professionale, non è affatto scontato. Lo è per noi, abitanti della società globale e complessa, che, per virtuosa necessità, abbiamo fatto della cura anche un lavoro. Non lo è stato per le età che ci hanno preceduto: la storia della medicina, accanto a quella della tecnica, ce lo testimonia. È allora nel contesto degli ultimi secoli che la “sanità”, fenomeno e pratica socio-politica, si è imposta come garante tanto della sopravvivenza quanto della “sana vita” di ogni cittadino. Il motore di questa enorme istituzione è composto da una rete di molteplici professionalità: medici, infermieri, farmacisti, ma anche operatori socio-sanitari, educatori e volontari. A tal proposito, dunque, riteniamo, come Fondazione Lavoroperlapersona, che la testimonianza diretta di “professionisti della cura” sia fondamentale per prendere coscienza non solo dei problemi di malasanità (che purtroppo pervasivamente colpiscono la nostra penisola) quanto, soprattutto, per ascoltare e condividere senso, significato e vittorie, ma anche difficoltà e crisi, di persone e professioni che agiscono nel cuore e per il cuore di un sistema sociale. Ancor di più se, eletti a eroi durante la pandemia da Covid-19, sono stati poi fugacemente dimenticati.
La Fondazione Lavoroperlapersona ETS è lieta di pubblicare il reportage a puntate dal titolo "Quale cura per il lavoro di cura? Storie di salute, diritti e lavoro" realizzato da Valentina Brini e Annelise D'Egidio nell'ambito della collaborazione con la Scuola di Reportage e Fotografia Jack London.
L’ultimo rapporto GIMBE sul SSN1 mette nero su bianco le proporzioni della carenza di personale infermieristico nel nostro Paese. Una situazione già di per sé critica, che appare ancor più allarmante se confrontata con i dati degli altri Paesi dell’area OCSE. In Italia si contano mediamente 6,5 infermieri ogni 1 000 abitanti, cioè poco al di sopra di Spagna (6,2) e Polonia (5,7) e non così distante da Ungheria (5,5), Lettonia (4,2) e Grecia (3,9). Le più virtuose sono Svizzera, Norvegia e Islanda: i nostri vicini elvetici, con ben 18,5 infermieri ogni 1 000 abitanti, ci superano addirittura di tre volte. Siamo dunque ben al di sotto sia della media OCSE (9,8) sia di quella dell’Unione Europea (9). Ma non è tutto. Se si considera il rapporto tra medici e infermieri, l’Italia scivola ancora più in basso, superata da Polonia, Ungheria e Lettonia. Magra consolazione: evitiamo per poco l’ultimo posto. Il dato resta comunque allarmante, giacché il nostro rapporto infermieri/medici è di appena 1,5, a fronte di una media OCSE di 2,6 e una media UE di 2,4. A peggiorare ulteriormente il quadro si aggiungono i salari. Secondo i dati disponibili, riferiti ai soli infermieri dipendenti da strutture pubbliche ospedaliere e calcolati in termini lordi, a parità di potere d’acquisto, la retribuzione italiana media ($ 48 931) risulta inferiore di almeno 10 000 dollari annui rispetto sia alla media OCSE ($ 58 395) che a quella UE ($ 57 040). È questa la necessaria premessa da tenere a mente per contestualizzare quanto, in quasi due ore di fitta conversazione nel giardino di casa sua, ci racconterà Pasquale. Sebbene i suoi quasi due metri d’altezza lo rendano una presenza che non passa inosservata – imponente ma nient’affatto minacciosa –, ciò che si è impresso più vividamente nella mia memoria sono alcune metafore e immagini ricorrenti del suo modo di esprimersi. È per questo che ho scelto di riprenderle, usandole come segnavia per orientarmi lungo i primi dieci anni, ricchi di svolte e cambiamenti, della sua carriera professionale. Un primo discrimine fondamentale è rappresentato dal vincolo contrattuale e, dunque, dalla differenza quintessenziale tra la libera professione e il lavoro dipendente (a termine) in ospedale. «Ho iniziato a lavorare subito dopo la laurea, nel 2017. Ero un interinale per l'USL dell'ospedale principale della zona: non ero padrone della mia vita lavorativa, ma sottoposto a logiche e tempi stabiliti dall'alto. Il caso ha voluto che fossi assegnato allo stesso reparto in cui avevo svolto il tirocinio l’anno prima: Medicina Oncologica. Pur trattandosi di un contesto estremamente delicato, era considerata una delle punte di diamante della struttura: si lavorava davvero bene. Lì ho imparato una lezione fondamentale per preservare la mia vita personale: lasciare in reparto ciò che accadeva durante il turno. Ci ho lavorato per un anno, e conservo molti bei ricordi. Tra questi, alcuni pazienti allo stadio terminale, che nonostante tutto trovavano la forza di sdrammatizzare. Qualcuno mi chiedeva perfino di accendergli una sigaretta. Ovviamente non gliela negavo. Come avrei potuto?» Il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’ospedale si protrae per un altro anno e lo vede in forza al reparto di Ortopedia, che però valuta in tutt’altro modo. «Cattiva organizzazione, tutto molto nebuloso. Sono andato in sofferenza, nonostante il mio amore viscerale per questa professione. Così, insieme a un collega, abbiamo deciso di aprire la partita IVA e lavorare per il 118 in giro per l’Italia. Stavo finalmente realizzando il mio sogno: la medicina di emergenza-urgenza è sempre stata il mio pallino. Mi annoio facilmente, e la vita di reparto finiva per opprimermi. Troppa gerarchia, troppi equilibri di potere. A mio avviso, un vero e proprio ginepraio che scoraggia l’innovazione. Dominano rigidità e la logica del “si è sempre fatto così”. Provare a cambiare approccio? Fuori discussione. Almeno finché sono rimasto nel pubblico, anno Domini 2023, la risposta era sempre la stessa: ‘Se non ti sta bene, lì è la porta!».
Probabilmente, se non avesse conosciuto la moglie, Pasquale avrebbe proseguito la sua attività da libero professionista. Da autonomo, si erano allineati tutti gli elementi che gli davano soddisfazione: l’adrenalina della medicina d’urgenza, l’esperienza nel suo campo d’elezione e, non da ultimo, la possibilità di viaggiare – una media di 60 000 chilometri l’anno. Verona, Vicenza, la riviera romagnola... addirittura quindici giorni di navigazione nel mare Adriatico, a bordo di una nave equipaggiata con un prototipo sperimentale del Politecnico di Torino, progettato per ricavare energia dal moto ondoso. La decisione di mettere su famiglia lo porta a rivedere le sue priorità, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra vita e lavoro. Di qui la scelta di partecipare a un bando di selezione per infermieri da destinare al reparto Emergenza-Urgenza, indetto dalla stessa USL per cui aveva già lavorato in passato. Ciò che accadrà all’indomani dell’assegnazione – prima presso il pronto soccorso di un piccolo ospedale della zona (2020-2022), poi in una seconda struttura, più grande, riaperta per motivi politici dopo la chiusura durante la pandemia (2022-2023) – rappresenterà uno snodo decisivo nella vita di Pasquale. E, al di là della sua vicenda personale, offre spunti significativi sulla gestione della sanità pubblica, ispirati – come lui stesso sintetizza con lucidità – al «solito gioco delle tre carte, imposto dalla deleteria indissolubilità del legame tra amministrazioni regionali e direzioni generali ospedaliere».
⁎
Ancor prima della diffusione delle piattaforme di intrattenimento on demand, le serie TV – soprattutto quelle nordamericane – riscuotevano già un grande successo di pubblico. Tra le più popolari negli anni dell’adolescenza di Pasquale (lo ricordo bene, dato che siamo più o meno coetanei), c’era E.R. – Medici in prima linea, un medical drama ambientato nel pronto soccorso di un grande ospedale della contea di Chicago. Come più tardi Grey’s Anatomy, Dr. House e molte altre, contribuì a diffondere un’immagine idealizzata della vita di corsia, trasmettendo al pubblico l’idea di un continuo alternarsi di casi straordinari e storie avvincenti. La realtà, però, è decisamente più prosaica: non di rado, il lavoro di chi si occupa di medicina d’urgenza consiste in notti trascorse ad attendere una chiamata, oppure nel gestire comportamenti aggressivi da parte di persone con dipendenze, che frequentemente si rifugiano in pronto soccorso in cerca di un riparo per la notte. Il fatto stesso che non esistano soluzioni alternative adeguate per supportare questa particolare tipologia di utenza meriterebbe un’attenta riflessione.
Ciò detto, la situazione conferma ancora una volta che i pronto soccorso sono il “canarino nella miniera” dello stato di salute complessivo dei servizi di assistenza territoriale. Non è affatto vero, comunque, che la professionalità si misuri in base al numero di codici rossi gestiti. Anzi, direi piuttosto il contrario: spesso, in contesti non segnati da calamità o conflitti, l’eroismo si manifesta nella ripetizione silenziosa di tanti piccoli – e talvolta meno piccoli – atti virtuosi. Tra questi, inserirei senz’altro la capacità di sopportare condizioni di lavoro altamente stressanti, senza il supporto di un reparto strutturato. Pasquale mi fa un elenco, ordinato per grado crescente di pericolosità: al livello base c’è la sala d’aspetto del pronto soccorso; segue un livello intermedio, rappresentato dall’automedica o dall’ambulanza; infine, il massimo livello di esposizione: la strada o l’abitazione del paziente. Il criterio di assegnazione su questa “scala di vulnerabilità” è dato dalla distanza dalla zona di comfort, definita da due elementi: la superiorità numerica degli operatori sull’utenza e la possibilità, tutt’altro che remota, di incorrere in minacce all’incolumità personale. «Ogni intervento in esterna è una sorpresa. Se c’è bisogno di richiedere il supporto delle forze di pubblica sicurezza, lo si scopre solo una volta arrivati sul posto. Se sei per strada e ci riesci, puoi chiuderti in auto. Se invece ti trovi all’interno di una casa che non conosci, allora lì te la devi giocare. E puoi solo sperare che quel giorno ti vada bene.» Prendo in prestito un’altra sua espressione: «Oggi il lavoro da libero professionista mi consente di spendermi come voglio col paziente. Di stare dentro al processo della cura, accompagnandolo in ogni fase, compresi gli ordini per il riassortimento delle scorte. Ne trae vantaggio il paziente e, di riflesso, ne sono soddisfatto io». Se pure estrapolate da un contesto diverso, le sue parole condensano perfettamente il senso profondo di una professione in cui il contatto umano rappresenta una base imprescindibile. Si tratta in buona percentuale di un contatto fisico ravvicinato: gesti, manovre, somministrazioni che presuppongono la fiducia del paziente, un certo suo abbandonarsi: af-fidarsi e con-fidare. Tuttavia, proprio a causa della prossimità fisica, specialmente in spazi ristretti o sovraffollati, il contatto può facilmente degenerare e tramutarsi nel suo contrario: lo scontro e la violenza. «Personalmente, probabilmente grazie alla mia stazza fisica, finché ho lavorato in pronto soccorso non ho mai subito aggressioni. Sono stato testimone di un pugno sferrato a un collega dal parente di un paziente in sala d’aspetto, preso dalla frenesia di sfogarsi col primo malcapitato per il protrarsi dei tempi d’attesa. Si lavora costantemente sotto pressione, tanto che la maggior parte dei miei ex colleghi è in perenne affanno. Quasi in ogni turno mi toccava ripetere all’utenza: “Chi aspetta è perché può aspettare. Se vedete entrare qualcuno ed essere portato direttamente oltre la porta divisoria vuol dire che ha la precedenza assoluta, perché non può aspettare”. Non tornerei mai e poi mai in ospedale. Oramai ho fatto le mie scelte, ma non nego che l’emergenza-urgenza mi manchi molto.»
Tutto si consuma nell’arco di poco più di un anno: da un singolo episodio – peraltro di modesta entità – prende avvio una catena di eventi. Come una valanga che, rotolando a valle, s’ingrossa mano a mano, si giunge ad un processo, che si conclude con un’assoluzione. Solo in apparenza un lieto fine: a rigore, sarebbe più corretto definirla una classica “vittoria di Pirro”. Sorprendentemente, dato il luogo in cui si svolge, l’esposizione dei fatti richiede molto meno tempo del racconto delle sue conseguenze. Accade che un’anziana affetta da demenza senile, già nota agli operatori, venga trasportata in pronto soccorso per uno stato di agitazione non più gestibile dalla badante che abitualmente la segue. Il medico chirurgo di turno, coadiuvato da Pasquale, è impegnato in quel momento in una procedura ben più delicata su un’altra paziente. Tuttavia, il vociare proveniente dall’accettazione spinge Pasquale a intervenire. D’accordo con il medico, e dopo aver constatato che la situazione può essere gestita in tranquillità, somministra alla donna una prima terapia. La paziente si calma e tutto sembra rientrare. L’arrivo della badante però riaccende la tensione: a quel punto, a gridare sono in due. Nel tentativo di placare gli animi, interviene anche il medico che, mentre Pasquale si occupa dell’anziana, prova a spiegarsi con la badante, convinta che all’anziana non siano state date le dovute attenzioni. Ma ogni tentativo si rivela vano, al che il medico, prendendola per i polsi, la invita garbatamente a sedersi e ad ascoltare. Nel giro di poco, la situazione torna alla calma. Tuttavia, a una settimana di distanza, la badante sporge denuncia contro il medico per lesioni, minacce e violenza privata. L’azienda ospedaliera, a sua volta, apre un procedimento disciplinare e – dopo aver ascoltato anche i testimoni presenti, tra cui naturalmente Pasquale – decide di applicare una trattenuta sulla busta paga del chirurgo, accompagnata da una nota scritta di demerito. Il medico, indignato soprattutto per la macchia inferta alla sua reputazione, si rivolge al tribunale competente. Constata l’impossibilità di una conciliazione tra le parti, il giudice ascolta tutti i testimoni per due volte e dà ragione al querelante. La sentenza condanna infatti l’azienda al pagamento delle spese legali, impone la restituzione dell’importo trattenuto, la cancellazione della nota di demerito e, previo benestare del medico stesso – nel frattempo dimessosi –, dispone il suo reintegro in organico. A quindici giorni dalla conclusione del processo, questi rientra in servizio e Pasquale sostiene la prova orale di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso la USL, che anche noi abbiamo ormai imparato a conoscere.
1 Si veda il 7o Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, in particolare il Capitolo 7, Il personale sanitario, pp. 124-128. Il rapporto è consultabile gratuitamente (previa registrazione) sul sito della Fondazione GIMBE: https://salviamo-ssn.it/attivita/rapporto/7-rapporto-gimbe.it-IT.html.
Valentina Brini Emiliana, classe 1991. Laureata in farmacia e nutrizione, sceglie di allontanarsi dal mondo sanitario dopo averne conosciuto da vicino le crepe e il logorio. Da sempre spinta da un bisogno di autenticità, ha trovato nella musica e nella fotografia i suoi linguaggi più veri. Viaggiatrice inquieta, attraversa luoghi e volti alla ricerca di qualcosa di vero. Cerca ancora dei buoni obiettivi fotografici e non.Annelise D'Egidio Origini lucane, studi in filosofia. Prima della scuola Jack London, esperienze lavorative tra loro eterogenee, ma accomunate dalla medesima precarietà contrattuale. In mezzo: viaggi, scoperte, incontri e trasferimenti. In sottofondo, tanta musica e molti podcast. Circondata da immancabili pile di libri, tuttora alla ricerca di un centro di gravità permanente.
Libri EllePì - Appunti di viaggio sul senso del lavoro
Il volume Appunti di viaggio sul senso del lavoro è un mosaico di riflessioni collettive che nasce dall’esperienza quindicennale della Fondazione Lavoroperlapersona ETS. Il libro raccoglie una serie di contributi pubblicati originariamente sul settimanale Voce della Vallesina e si configura come un itinerario di pensiero e testimonianza che intreccia economia, etica, cultura e comunità.
Fin dalle prime pagine, Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione, introduce il progetto come parte di un percorso più ampio di educazione e ricerca volto a riscoprire il significato profondo del lavoro come atto sociale e non solo economico. Il lavoro viene descritto come spazio di incontro, di dignità e di generatività: un ambito in cui l’uomo realizza sé stesso contribuendo al bene comune.
Le cinque sezioni del volume — Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e Senso del lavoro — costruiscono una narrazione corale in cui il lavoro viene raccontato attraverso molteplici sguardi: quello della cura e dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia, ma anche del desiderio, della creatività e della felicità. Ogni capitolo affronta un nodo cruciale della contemporaneità: la mancanza di lavoro come assenza di dignità, il valore invisibile del lavoro di cura, la costruzione della pace attraverso l’impegno quotidiano, la sfida dell’inclusione, la responsabilità delle imprese, la sicurezza e la povertà lavorativa, fino a interrogarsi su come il lavoro possa diventare ancora un’esperienza di senso e di libertà.
La scrittura a più voci — sobria, essenziale, eppure densa di pensiero — rende il libro un vero laboratorio di umanità: ogni contributo riflette un impegno educativo e culturale volto a “coltivare l’umano nell’economia”. L’opera non si limita a una riflessione teorica, ma propone un dialogo vivo con il territorio e con le persone, restituendo la concretezza di un impegno civile e comunitario.
In un’epoca in cui il lavoro è spesso ridotto a mero strumento produttivo o a variabile economica, Appunti di viaggio sul senso del lavoro invita a recuperare la dimensione etica, relazionale e spirituale del lavoro come luogo di costruzione di sé e del mondo. È, in definitiva, un libro che parla di responsabilità e di speranza, e che offre alla storia della Fondazione un tassello prezioso nella sua missione di diffondere una cultura del lavoro capace di mettere sempre la persona al centro.
Clicca sull'immagine per scaricare il volume!
#Blog EllePì - Il lavoro? Un gioco da ragazzi!
Sabato 25 ottobre presso il suggestivo Palazzo Luminari di Rosora si è svolto un evento dal titolo “Un gioco… da ragazzi!”, pensato per mescolare divertimento e riflessione attorno al tema del lavoro. Insieme a Sonia Palermo - pedagogista del lavoro - e Chiara Pallotta - educatrice della Fondazione - i ragazzi e le ragazze del territorio di Rosora hanno esplorato il senso del lavoro attraverso un percorso ludico-educativo che ha preso spunto da personaggi illustri della scienza, della letteratura, dell’economia e della filosofia. Il gioco è nato dalla volontà di trasformare in una dinamica avventura intergenerazionale la pubblicazione “Appunti di viaggio sul senso del lavoro”.
L’evento è stato vissuto come momento di crescita, scoperta e partecipazione: la dimensione del gioco, accostata alla riflessione sulle vocazioni e sul senso del lavoro, ha permesso ai partecipanti di confrontarsi attivamente con idee, valori e storie che – al di là del “fare” – parlano di “essere” e “essere-con”. Tra i valori richiamati spiccano il rispetto dell’unicità della persona, la dignità del lavoro come espressione dell’essere umano, la diversità come ricchezza da valorizzare, la solidarietà e l’imprenditività come ingredienti di una cittadinanza accogliente, aperta e creativa. È proprio in questo spirito che l’iniziativa “Un gioco… da ragazzi!” ha preso forma: non solo un momento ludico-ricreativo, ma un’occasione per coltivare una cultura del lavoro che rimettere la persona – e non solo il profitto o la produttività – al centro.
I ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di scoprire – giocando – come il lavoro non sia solo un “compito” da svolgere, ma un orizzonte di senso che lega passato e futuro, generazioni diverse e aspirazioni personali. Emerge chiaramente come il gioco, inteso come palestra di vita, diventi strumento educativo: attraverso la cooperazione, la condivisione, la negoziazione e il rispetto dell’altro i partecipanti sono stati invitati a sperimentare attivamente i relativi valori. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo: la loro presenza ha reso tangibile che educare al lavoro significa anche educare alle relazioni, alla responsabilità, alla libertà e alla creatività. E nella comunità di Rosora questo messaggio ha trovato terreno fertile. L’auspicio è che quanto vissuto sia solo un inizio, capace di generare ulteriori occasioni di dialogo intergenerazionale, laboratori di scoperta, e momenti in cui il lavoro diventa strumento per fiorire come persona.
agenda
#EllePì Rosora - Appunti di un viaggio sul senso del lavoro
Si è svolto lo scorso sabato 29 novembre al Teatro Comunale di Poggio San Marcello un evento originale e significativo promosso dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS in collaborazione con il giornale Voce della Vallesina. L'occasione ha visto la presentazione e la riflessione sul volume "Appunti di viaggio. Coltivare l’umano nell’economia e nel lavoro", una raccolta di contributi frutto di anni di riflessioni, precedentemente pubblicate sulle pagine del settimanale locale.
Il libro, è un prezioso contributo per orientarsi nelle sfide del presente, ed è una riflessione corale che tocca temi cari alla Fondazione come: Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e, naturalmente, il Senso del lavoro. L'iniziativa ha voluto superare la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di autentico dialogo intergenerazionale. Per questo motivo, il testo è stato consegnato ai primi cittadini del territorio - senior e junior - per raccogliere le loro testimonianze e riflessioni.
L'evento, iniziato dopo i saluti di Fabrizio Chiappa, sindaco di Poggio San Marcello, del Presidente della Fondazione, Gabriele Gabrielli, con la partecipazione di Beatrice Testadiferro, Direttrice di Voce della Vallesina, e la moderazione di Michele Cardinali, collaboratore della Fondazione e docente di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Macerata, ha visto una partecipazione d'eccezione. Amministratori e cittadini si sono disposti in un grande cerchio per intavolare una riflessione condivisa sui temi centrali tratti dal volume. Ospiti dell’evento: Giuseppe Montesi (Sindaco di Castelplanio), Nico Consoli (Assessore di Castelplanio), Sebastiano Mazzarini (Vicesindaco di Maiolati Spontini), Luca Possanzini (Sindaco di Mergo), Paolo Bernardini (Vicesindaco di Rosora) e Alessandra Ceccucci (Consigliera di Rosora). Insieme a loro, hanno dialogato tre giovani mini sindaci: Enea (Poggio San Marcello), Riccardo (Mergo) e Alice (Maiolati Spontini). Il dibattito ha toccato argomenti cruciali come il lavoro e il suo senso, economia, vocazioni, pregiudizi intergenerazionali e molto altro ancora.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, inclusi i cittadini del territorio, che hanno preso parte all’evento e che sono usciti dalla splendida sala del teatro con l’energia della speranza. L’incontro si è concluso con un interrogativo aperto, che suona come un impegno per il futuro: come rendere stabile e continuativo questo dialogo intergenerazionale per farlo diventare il format educativo e di cittadinanza attiva di questo territorio? L'evento ha confermato lo stretto rapporto tra la Fondazione Lavoroperlapersona ETS e Voce della Vallesina, riaffermando l'importanza di stimolare la riflessione pubblica sul senso profondo del lavoro.
Webinar EllePì - Costruire la parità di genere nel lavoro
Costruire la parità di genere nel lavoroQuali i passi già fatti e quanta strada ancora da fare? giovedì 20 novembre - ore 18:00
Una mattina come tante, Ludovica accompagna il figlio all’asilo e la figlia a scuola; torna a casa, finisce di sistemare la cucina e accende il pc alle 9. Un’ora dopo squilla il telefono; è la maestra dell’asilo: suo figlio sta male. Ludovica va a prenderlo, lo porta a casa e ricomincia a lavorare. Risponde a qualche mail e di tanto in tanto va a vedere come sta, cercando di dividersi come meglio può. Ed ecco che un duplice senso di colpa si fa avanti: si sente una lavoratrice non totalmente concentrata e improduttiva, e si sente una madre non abbastanza attenta e di supporto per il figlio. Eppure, Ludovica sta mettendo anima e cuore in entrambi i mondi.
Ludovica è una donna che ha scelto di raccontare su Instagram le difficoltà di una quotidianità in cui i molteplici ruoli che ricopre, gli stessi ruoli che la rendono felice, la fanno sentire inadeguata. Questo racconto non rappresenta un caso individuale, ma una condizione collettiva: il modo in cui le donne abitano il mondo del lavoro conosce sfide che chiedono di essere affrontate a livello sociale, non lasciate a gravare sulla sfera personale. Secondo una stima del World Economic Forum, mantenendo l’andamento attuale, a livello globale sarebbero necessari circa 135 anni per raggiungere la piena parità di genere nel mercato del lavoro[1].
Tra le quattro dimensioni incluse dal World Economic Forum nell’indice globale di divario di genere, la “partecipazione all’economia e opportunità” è una delle aree in cui sono stati fatti maggiori progressi verso la parità di genere; tuttavia, è ancora uno degli ambiti dove il divario è tra i maggiori (il sottoindice relativo è pari al 61%, dove il 100% rappresenta la parità di genere). Se il sottoindice globale relativo al livello di istruzione sta raggiungendo buoni livelli, non sempre l’accesso al sistema educativo si traduce in un ingresso o in una permanenza equi nel mercato del lavoro. Nella classifica mondiale, l’Italia si trova al 117° posto, con un sottoindice di partecipazione all’economia e opportunità pari a 0,599 (dove 1 rappresenta la parità di genere)[2].
Le principali aree critiche sono:
il tasso di occupazione femminile, che “nel (…) 2024 risulta inferiore di 12,6 punti alla media UE (…), rimanendo il valore più basso tra i ventisette paesi dell’Unione europea”[3];
il divario retributivo per lavori a parità di mansioni e qualifiche. Particolarmente importante è la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva[4], che consente di chiedere al datore di lavoro i livelli retributivi medi classificati per genere delle categorie che svolgono lavori di pari valore e i criteri utilizzati per determinare la progressione della retribuzione;
la stabilità occupazionale (frequente è l’utilizzo di contratti precari e part-time involontari, nonché l’interruzione lavorativa);
le opportunità di avanzamento di carriera e di accesso a posizioni di leadership.
La mattinata di Ludovica è un esempio semplice ma emblematico di come la parità di genere sia una tematica che abbraccia tutte le sfere della vita e dell’identità delle donne, poiché la complessità delle casistiche quotidiane richiede di attraversare dinamicamente la “barriera” tra vita personale e lavoro, bilanciando responsabilità ed energie.
In questo quadro, come il sistema culturale impatta sulla costruzione di un ambiente più o meno equo? Come il ruolo sociale delle donne incide sulle modalità di gestione del loro tempo? Quali sono i settori, le funzioni e i ruoli dove il divario di genere è maggiore e perché? Il divario ha un peso diverso a seconda della fascia di reddito? Quali sono gli ostacoli invisibili che influenzano la vita lavorativa di una donna? Quali strumenti, sia a livello sociale sia organizzativo, agevolano concretamente la parità di genere e quali interventi hanno uno scarso impatto oltre la superficie? È importante considerare che l’obiettivo della parità di genere nel lavoro, che trova fondamento nell’articolo 37 della Costituzione italiana, ha una forte rilevanza sia sociale sia economica: promuoverla “potrebbe stabilizzare il rapporto occupazione/popolazione nella maggior parte dei paesi dell’OCSE”[5].
Non si tratta di una meta da raggiungere, ma di un obiettivo da costruire e ricostruire costantemente in relazione all’evoluzione del contesto economico-sociale nel corso del tempo e nelle diverse geografie. La mappa che può fungere da guida in questo percorso va tracciata man mano, seguendo due indicazioni imprescindibili segnalate dall’OIL: “analizzare e affrontare (…) le specifiche esigenze di donne e uomini e promuovere interventi mirati per consentire loro di partecipare in egual misura al mercato del lavoro”[6]; occorre partire dall’analisi dei bisogni per giungere alla progettazione di soluzioni rispondenti alle necessità intercettate.
[1] La stima si basa su una proiezione dell’incremento percentuale dell’Economic Participation and Opportunity Gap registrato dal 2006 al 2025.Global Gender Gap Report 2025, insight report, giugno 2025, World Economic Forum.[2] Global Gender Gap Report 2025, insight report, giugno 2025, World Economic Forum.[3] Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità, documento di sintesi, 6 marzo 2025, CNEL-ISTAT.[4] Direttiva UE 2023/970[5] Prospettive dell’occupazione OCSE 2025: Italia, 2025, OECD.[6] Parità di genere nel mondo del lavoro, n.d., Organizzazione Internazionale del Lavoro. https://www.ilo.org/it/aree-tematiche/parita-di-genere-nel-mondo-del-lavoro
PARTECIPA AL WEBINARCOMPILANDO IL FORM SOTTOSTANTE!
[contact-form-7 id="c3918ca" title="Webinar EllePì - Parità di genere"]
Luigi Alici, la Speranza tra teologia e storia: "Una Virtù Sovversiva"
La speranza cristiana non nasce dalla mera antropologia del desiderio umano, ma è una risposta che scaturisce da una teologia della grazia; per questo, non è un sentimento che si fonda su un bisogno o una domanda, ma su una verità che è inconciliabile con qualsiasi forma di egemonia dogmatica. La speranza cristiana, dunque, non può rivendicare uno spazio privilegiato nella scena pubblica, proprio perché essa è una verità che vive nell'orizzonte del "non ancora", un luogo dove l'uomo è chiamato a rispondere a un bene che già lo sovrasta. Ma come si può trasmettere questa speranza nel mondo laico? Come possiamo darle un passaggio nelle nostre esistenze quotidiane? La via potrebbe trovarsi nel dialogo tra la speranza cristiana e quella sociale, entrambe accomunate dal destino comune dell'umanità: la strada su cui insieme si cammina continuando a domandarsi e a domandare. Questi i temi della lectio di Luigi Alici - professore emerito di Filosofia Morale presso l'Università di Macerata - che ha aperto l'ultima giornata del Film Festival Offida 2025.
Il disincanto della speranza
Oggi, la speranza sembra essere una parola svuotata di significato. Poche persone sono in grado di nutrire speranze in grado di turbare l’ordine stabilito. La speranza è diventata una speranza moralistica, addomesticata e banalizzata, incapace di sfidare la realtà e di promettere una salvezza totale, ,e allora cosa possiamo fare di una speranza che non disturba e che non sembra più capace di mutare nulla? Per Alici è come se vivessimo una speranza "senza aspettative", che si riduce a un immobilismo privo di futuro. In fondo, il nostro rapporto con la speranza assomiglia molto a quello di un condannato a morte che ha la possibilità di scegliere l'ultimo pasto: una speranza che non cambia nulla, che ci lascia ancorati a un presente senza un vero orizzonte.
Gabriel Marcel definisce la speranza come un "problema e mistero", un mistero che ci sfida a riconoscere l’eccedenza del bene di fronte al trionfo del male. Il professore spiega che quando vediamo il male prevalere, la speranza cristiana ha il dovere di insorgere: il riconoscimento che, pur di fronte alla sofferenza e alla morte, il bene non può essere annientato. La speranza cristiana, quindi, non è solo una virtù che si situa nel mezzo, come il coraggio o la giustizia, ma è una virtù che sovverte. È una speranza che non può mai peccare per eccesso, ma solo per difetto. È una speranza che ci spinge a guardare oltre, a non accontentarci di un'illusoria giustizia, ma a cercare una redenzione che non dipenda dal nostro potere.
La speranza cristiana, quindi, nasce dal disincanto, dalla consapevolezza della superiorità del bene di fronte al male. È una speranza che non promette facili soluzioni, ma che, al contrario, riconosce il rischio e l'incertezza dell’esistenza. San Paolo, come la sua discepola Tecla, parlava di una "grazia eccedente", di un amore che trascende le nostre fragilità e che nessuna forza può annullare. La speranza cristiana non nasce dal vuoto di un desiderio, ma da un bene che già esiste. Non è una speranza che si fonda su un futuro incerto, ma, come ha detto Alici "sulla certezza di un amore divino che non ci abbandona mai".
Questa speranza, tuttavia, avvisa Alici, non può esistere senza un contesto. La speranza è sempre una realtà relazionale: non può mai essere solo "Io", ma è sempre "noi". La speranza muore quando viene afflitta dalla "fase storica" ed escatologica che riduce l'orizzonte umano a unicamente temporale, limitando le possibilità dell'uomo a un destino che sembra già segnato. La nostra cultura, oggi, vive questo tipo di contraddizione: da un lato, l'autocensura politica che minaccia di farci dimenticare l'annuncio della resurrezione, dall'altro, la tendenza ad accettare una visione della vita che non considera più la morte come un passaggio, ma come un punto finale. Viviamo in un mondo che ha smesso di vedere la speranza come un'aspirazione verso qualcosa che va oltre il nostro presente.
La speranza e il "presentismo": tra il marxismo e la gnosi
Il "presentismo" è una delle tentazioni più forti del nostro tempo, quella di ridurre il tempo a un solo, eterno presente, come se l'eternità e la storia fossero in conflitto. Eppure, come sottolineano filosofi come Bauman, la speranza non può essere disincarnata dal contesto storico. In effetti, negli anni '60, quando sembravano finire le grandi ideologie e con esse la promessa di un futuro migliore, il tentativo di fermare il tempo post-bellico sembrava promettere un mondo migliore. Ma oggi ci ritroviamo in un contesto simile, anche se più desolato, dove la lotta per la libertà sembra essersi affievolita, e le organizzazioni che una volta portavano speranza sono ridotte a ombre di ciò che furono.
Un autore interessante da questo punto di vista è Ernst Bloch, che nel contesto del marxismo ha teorizzato una "speranza eretica". Bloch rifiuta la visione di Marx secondo cui la religione sarebbe l'oppio dei popoli, ma al contrario vede nel cristianesimo un'utopia che cammina con piedi umani. L’ontologia del "non ancora" è il luogo dove l’impossibile potrebbe realizzarsi. La speranza è, dunque, un atto di fede storica, che non guarda a un aldilà, ma che si radica nella realtà concreta e quotidiana. In questo, Bloch si fa interprete di una speranza che è sempre storica, che nasce nel tempo, nella lotta, e che non ha mai una fine definitiva. Ma come direbbe Simone Weil, "a noi non è concesso di avanzare in linea verticale, è nella storia che dobbiamo vivere il tirocinio della speranza". La speranza non si trova fuori dalla storia, ma in essa, nella libertà di scegliere, di lottare, di resistere.
La speranza come responsabilità sociale
La pandemia, infine, ha accentuato la divisione tra libertà individuali e responsabilità pubbliche, un conflitto che ha aperto la strada a un nuovo colonialismo tecnologico. I politici, invece di offrire speranza, sembrano incapaci di immaginare un futuro migliore, mentre le disuguaglianze crescono e la libertà sembra un'illusione. Ma la speranza non può essere solo una reazione a una condizione di ingiustizia: deve partire dal riconoscimento del bene e della persona, dal senso di responsabilità che nasce dalla nostra relazione con gli altri.
In questo senso, la speranza cristiana può anche essere vista come una risposta al senso di morte che sembra affliggere il nostro mondo. Come scrive Von Balthasar, la speranza cristiana inizia là dove non c'è più speranza, nel buio della morte, e si estende, trasformandosi in solidarietà, in una speranza che va prima di tutto a favore delle vittime, degli oppressi, di chi non ha voce. La speranza, dunque, chiude il professore Alici, "è una virtù sovversiva". "Non è mai banale, non è mai semplice, ma è sempre un segno di resistenza", continua. In un mondo che sembra sempre più disincantato e privo di visioni future, la speranza è la luce che non smette di brillare, anche nelle tenebre. È un respiro che dà vita a ogni persona, e la fiducia in essa è l'ossigeno che permette all'umanità di sopravvivere, di rialzarsi, di lottare. E forse, in questo dialogo tra fede e storia, tra speranza cristiana e speranza umana, si gioca una parte fondamentale del nostro destino.
Un gioco... da ragazzi
Sabato 25 ottobre, alle 17:00, palazzo Luminari di Rosora
Quanto può essere avvincente l’avventura di un viaggio insieme ai grandi della storia? Lasciarsi guidare dal sapere di uomini e donne che hanno raccontato il Senso del Lavoro?
È questa l’esperienza ludico-educativa che la Fondazione lavoroperlapersona ETS propone ai ragazzi e alle ragazze, per esplorare i significati e i sensi del lavoro, giocando con i protagonisti della scienza, della letteratura, dell’economia, della filosofia… Un momento per riflettere insieme sul passato e costruire un futuro dignitoso e sostenibile. Facendo appello alla storia, il gioco, in particolare tra individui di generazione differente, è sempre stato uno specchio del contesto sociale e culturale della comunità di riferimento, rivelandosi sia intrattenimento che preparazione alla vita adulta: passaggio di conoscenze, valori e partecipazione gioiosa, una "palestra di vita" per imparare la cooperazione, la condivisione, la negoziazione e il rispetto dell'altro.
Da dove nasce il progetto? Dalla volontà di rendere fruibile in una nuova veste, costruita per i più giovani, la pubblicazione edita dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS dal titolo “Appunti di viaggio sul senso del lavoro”, una raccolta di brevi articoli che testimoniano il dialogo aperto con il territorio e le sue comunità (Gabrielli 2025).
Un viaggio, quindi, che prevede l’utilizzo di strumenti ludici quali un cartellone di riferimento e due mazzi di carte. E proprio le carte rappresentano quel legame intergenerazionale, che favorisce la voglia di giocare con oggetti manipolabili dal sapore antico eppure così contemporanei. Sfide di abilità, giochi di parole e memoria condivisa… Così come il cartellone: il campo di gioco che è anche patrimonio, conoscenza comune.
L’appuntamento è per sabato 25 ottobre, alle 17:00, presso il palazzo Luminari di Rosora.
Webinar EllePì - Lavoro e cambiamento climatico: una prospettiva politico-legislativa
Abituati a pensare il cambiamento climatico esclusivamente come problema di natura ambientale, rischiamo di tralasciare le molteplici sfaccettature di una questione ben più ampia. La realtà, infatti, è che esso influenza, direttamente o indirettamente, tutte le forme dell’agire umano. L’attività lavorativa, in questo senso, sta subendo dei cambiamenti che possono causare disorientamento tanto a livello personale quanto sul piano politico-legislativo. Talvolta percepiti come rischi, talvolta come occasioni e opportunità, indagare attentamente gli impatti del cambiamento climatico sul mondo del lavoro si rivela, quindi, necessario: che l’argomento sia la trasformazione del mercato del lavoro o che sia il mutamento delle professionalità, delle condizioni di lavoro, delle tutele e della formazione dei lavoratori, emerge sempre più l’urgenza di una collaborazione tra persone, enti, aziende e decisori politici per ricomporre una bussola capace di orientarci in tempi incerti.
A proposito delle condizioni di lavoro, tema centrale e ampiamente trattato nello studio del Centro di Ricerca Ellepì curato da Paolo Bonini e Gabriele Gessini, è interessante osservare come il lungo corso legislativo italiano, dall’entrata in vigore della Costituzione fino ai giorni nostri, abbia spostato l’interpretazione e l’applicazione della sicurezza sul lavoro «da una visione reattiva […] (centrata sul danno) a una concezione preventiva e integrata (centrata sul benessere organizzativo)»[1]. Un mutamento paradigmatico che “veste” il significato della parola salute non solo dell’attenzione per l’incolumità del lavoratore, ma anche e soprattutto della cura del suo benessere psicologico e sociale tramite l’organizzazione di contesti lavorativi nei quali viene tutelata la sua personalità e che, oggi, trovano nella questione climatica un’ulteriore opportunità per ri-pensarsi: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, infatti, stima che, ogni anno, circa 23 milioni infortuni sul lavoro sono collegati alle temperature troppo elevate[2].
Al livello, invece, delle sollecitazioni per le trasformazioni del mercato e di settori produttivi in termini sostenibili, gli interrogativi sono molteplici: come farlo e con quale urgenza? Che ruolo hanno le politiche occupazionali nei processi di riconversione ecologica? Come poter strutturare una formazione sensibile alle necessità ambientali e del lavoro dignitoso e sicuro? Laddove il lessico e il vocabolario dell’industria e della politica si ampliano di nuove terminologie come “lavoro verde”, “industria 5.0”, “stress termico” e “co-benefici”, è bene, infatti, chiedersi se esse ci parlano delle possibili vie di uscita da una condizione di emergenza globale o se rischiano di diventare parole-trappola vuote di significato atte a riprodurre un sistema che di mutare non ha proprio intenzione.
In ultimo, ancora una volta è bene ricordare, per non disorientarci all’interno della generatività frenetica che scaturisce dal rapporto fra cambiamento climatico e lavoro e nella corsa urgente di trovare soluzioni adeguate che armonizzino necessità produttiva e cura dell’ambiente, la saggezza necessaria richiesta per porre la persona sempre al centro di ogni nostra azione: la tutela della sua dignità, libertà e capacità di agire e decidere. Ancor più, in questo caso specifico, della relazione che essa intrattiene con la Terra che la ospita, lavorandola e custodendola.
[1] Bonini P., Gessini G., Lavoro e cambiamento climatico. Una prospettiva politico-legislativa, Edizioni Lavoroperlapersona, 2025, p. 16.[2] Organizzazione Internazionale del Lavoro: https://unric.org/it/rapporto-oil-alte-temperature-sul-lavoro-implicazioni-per-la-salute-e-sicurezza/
PARTECIPA AL WEBINARCOMPILANDO IL FORM SOTTOSTANTE!
[contact-form-7 id="2c0751f" title="Webinar EllePì - Lavoro e cambiamento climatico"]
blog
Tombola Intergenerazionale 2025
Rosora, 20 dicembre
Offida, 22 dicembre
La Fondazione Lavoroperlapersona ETS, come ogni anno, presenta la sua versione di Tombola , il gioco delle feste che accomuna le generazioni! Giunta quest’anno alla sua settima edizione, la Tombola Intergenerazionale EllePì, nella cornice progettuale FuturoAnteriore, è un momento per incontrarsi, condividere, chiacchierare, riflettere di lavoro e non solo… giocando.
Chi gioca:
Le squadre “intergenerazionali” sono composte da due o più giocatori di età differente: nonni e nipoti oppure genitori e figli, oppure zii e nipoti. È fondamentale che siano diverse le generazioni presenti in ogni squadra.
Come si gioca:
Come ogni tombola che si rispetti, cartellone, cartelle e numeri sono gli strumenti del gioco. Ogni squadra può richiedere una o due cartelle per componente. Tra i 90 numeri sono inseriti anche i numeri “attivi”: ogni numero speciale prevede una attività o sfida o riflessione.
Chi vince:
Sono premiate: la terna, la quaterna, la cinquina, tombola e tombolino (la seconda tombola).
Gli appuntamenti per la Tombola Intergenerazionale 2025:
sabato 20 dicembre al Palazzo Luminari di Rosora, alle 17:00
lunedì 22 dicembre nella chiesa di San Michele, ad Offida, alle 16:30.
Per iscrivere la propria squadra, basta compilare il modulo qui sotto
[contact-form-7 id="bdff202" title="Iscrizione Tombola Intergenerazionale 2025"]
#EllePì Rosora - Appunti di un viaggio sul senso del lavoro
Si è svolto lo scorso sabato 29 novembre al Teatro Comunale di Poggio San Marcello un evento originale e significativo promosso dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS in collaborazione con il giornale Voce della Vallesina. L'occasione ha visto la presentazione e la riflessione sul volume "Appunti di viaggio. Coltivare l’umano nell’economia e nel lavoro", una raccolta di contributi frutto di anni di riflessioni, precedentemente pubblicate sulle pagine del settimanale locale.
Il libro, è un prezioso contributo per orientarsi nelle sfide del presente, ed è una riflessione corale che tocca temi cari alla Fondazione come: Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e, naturalmente, il Senso del lavoro. L'iniziativa ha voluto superare la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di autentico dialogo intergenerazionale. Per questo motivo, il testo è stato consegnato ai primi cittadini del territorio - senior e junior - per raccogliere le loro testimonianze e riflessioni.
L'evento, iniziato dopo i saluti di Fabrizio Chiappa, sindaco di Poggio San Marcello, del Presidente della Fondazione, Gabriele Gabrielli, con la partecipazione di Beatrice Testadiferro, Direttrice di Voce della Vallesina, e la moderazione di Michele Cardinali, collaboratore della Fondazione e docente di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Macerata, ha visto una partecipazione d'eccezione. Amministratori e cittadini si sono disposti in un grande cerchio per intavolare una riflessione condivisa sui temi centrali tratti dal volume. Ospiti dell’evento: Giuseppe Montesi (Sindaco di Castelplanio), Nico Consoli (Assessore di Castelplanio), Sebastiano Mazzarini (Vicesindaco di Maiolati Spontini), Luca Possanzini (Sindaco di Mergo), Paolo Bernardini (Vicesindaco di Rosora) e Alessandra Ceccucci (Consigliera di Rosora). Insieme a loro, hanno dialogato tre giovani mini sindaci: Enea (Poggio San Marcello), Riccardo (Mergo) e Alice (Maiolati Spontini). Il dibattito ha toccato argomenti cruciali come il lavoro e il suo senso, economia, vocazioni, pregiudizi intergenerazionali e molto altro ancora.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, inclusi i cittadini del territorio, che hanno preso parte all’evento e che sono usciti dalla splendida sala del teatro con l’energia della speranza. L’incontro si è concluso con un interrogativo aperto, che suona come un impegno per il futuro: come rendere stabile e continuativo questo dialogo intergenerazionale per farlo diventare il format educativo e di cittadinanza attiva di questo territorio? L'evento ha confermato lo stretto rapporto tra la Fondazione Lavoroperlapersona ETS e Voce della Vallesina, riaffermando l'importanza di stimolare la riflessione pubblica sul senso profondo del lavoro.
#Reportage EllePì - Violenza - Capitolo 1 parte 1
Che si associ l’atto di cura ad una precisa e determinata figura professionale, non è affatto scontato. Lo è per noi, abitanti della società globale e complessa, che, per virtuosa necessità, abbiamo fatto della cura anche un lavoro. Non lo è stato per le età che ci hanno preceduto: la storia della medicina, accanto a quella della tecnica, ce lo testimonia. È allora nel contesto degli ultimi secoli che la “sanità”, fenomeno e pratica socio-politica, si è imposta come garante tanto della sopravvivenza quanto della “sana vita” di ogni cittadino. Il motore di questa enorme istituzione è composto da una rete di molteplici professionalità: medici, infermieri, farmacisti, ma anche operatori socio-sanitari, educatori e volontari. A tal proposito, dunque, riteniamo, come Fondazione Lavoroperlapersona, che la testimonianza diretta di “professionisti della cura” sia fondamentale per prendere coscienza non solo dei problemi di malasanità (che purtroppo pervasivamente colpiscono la nostra penisola) quanto, soprattutto, per ascoltare e condividere senso, significato e vittorie, ma anche difficoltà e crisi, di persone e professioni che agiscono nel cuore e per il cuore di un sistema sociale. Ancor di più se, eletti a eroi durante la pandemia da Covid-19, sono stati poi fugacemente dimenticati.
La Fondazione Lavoroperlapersona ETS è lieta di pubblicare il reportage a puntate dal titolo "Quale cura per il lavoro di cura? Storie di salute, diritti e lavoro" realizzato da Valentina Brini e Annelise D'Egidio nell'ambito della collaborazione con la Scuola di Reportage e Fotografia Jack London.
L’ultimo rapporto GIMBE sul SSN1 mette nero su bianco le proporzioni della carenza di personale infermieristico nel nostro Paese. Una situazione già di per sé critica, che appare ancor più allarmante se confrontata con i dati degli altri Paesi dell’area OCSE. In Italia si contano mediamente 6,5 infermieri ogni 1 000 abitanti, cioè poco al di sopra di Spagna (6,2) e Polonia (5,7) e non così distante da Ungheria (5,5), Lettonia (4,2) e Grecia (3,9). Le più virtuose sono Svizzera, Norvegia e Islanda: i nostri vicini elvetici, con ben 18,5 infermieri ogni 1 000 abitanti, ci superano addirittura di tre volte. Siamo dunque ben al di sotto sia della media OCSE (9,8) sia di quella dell’Unione Europea (9). Ma non è tutto. Se si considera il rapporto tra medici e infermieri, l’Italia scivola ancora più in basso, superata da Polonia, Ungheria e Lettonia. Magra consolazione: evitiamo per poco l’ultimo posto. Il dato resta comunque allarmante, giacché il nostro rapporto infermieri/medici è di appena 1,5, a fronte di una media OCSE di 2,6 e una media UE di 2,4. A peggiorare ulteriormente il quadro si aggiungono i salari. Secondo i dati disponibili, riferiti ai soli infermieri dipendenti da strutture pubbliche ospedaliere e calcolati in termini lordi, a parità di potere d’acquisto, la retribuzione italiana media ($ 48 931) risulta inferiore di almeno 10 000 dollari annui rispetto sia alla media OCSE ($ 58 395) che a quella UE ($ 57 040). È questa la necessaria premessa da tenere a mente per contestualizzare quanto, in quasi due ore di fitta conversazione nel giardino di casa sua, ci racconterà Pasquale. Sebbene i suoi quasi due metri d’altezza lo rendano una presenza che non passa inosservata – imponente ma nient’affatto minacciosa –, ciò che si è impresso più vividamente nella mia memoria sono alcune metafore e immagini ricorrenti del suo modo di esprimersi. È per questo che ho scelto di riprenderle, usandole come segnavia per orientarmi lungo i primi dieci anni, ricchi di svolte e cambiamenti, della sua carriera professionale. Un primo discrimine fondamentale è rappresentato dal vincolo contrattuale e, dunque, dalla differenza quintessenziale tra la libera professione e il lavoro dipendente (a termine) in ospedale. «Ho iniziato a lavorare subito dopo la laurea, nel 2017. Ero un interinale per l'USL dell'ospedale principale della zona: non ero padrone della mia vita lavorativa, ma sottoposto a logiche e tempi stabiliti dall'alto. Il caso ha voluto che fossi assegnato allo stesso reparto in cui avevo svolto il tirocinio l’anno prima: Medicina Oncologica. Pur trattandosi di un contesto estremamente delicato, era considerata una delle punte di diamante della struttura: si lavorava davvero bene. Lì ho imparato una lezione fondamentale per preservare la mia vita personale: lasciare in reparto ciò che accadeva durante il turno. Ci ho lavorato per un anno, e conservo molti bei ricordi. Tra questi, alcuni pazienti allo stadio terminale, che nonostante tutto trovavano la forza di sdrammatizzare. Qualcuno mi chiedeva perfino di accendergli una sigaretta. Ovviamente non gliela negavo. Come avrei potuto?» Il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’ospedale si protrae per un altro anno e lo vede in forza al reparto di Ortopedia, che però valuta in tutt’altro modo. «Cattiva organizzazione, tutto molto nebuloso. Sono andato in sofferenza, nonostante il mio amore viscerale per questa professione. Così, insieme a un collega, abbiamo deciso di aprire la partita IVA e lavorare per il 118 in giro per l’Italia. Stavo finalmente realizzando il mio sogno: la medicina di emergenza-urgenza è sempre stata il mio pallino. Mi annoio facilmente, e la vita di reparto finiva per opprimermi. Troppa gerarchia, troppi equilibri di potere. A mio avviso, un vero e proprio ginepraio che scoraggia l’innovazione. Dominano rigidità e la logica del “si è sempre fatto così”. Provare a cambiare approccio? Fuori discussione. Almeno finché sono rimasto nel pubblico, anno Domini 2023, la risposta era sempre la stessa: ‘Se non ti sta bene, lì è la porta!».
Probabilmente, se non avesse conosciuto la moglie, Pasquale avrebbe proseguito la sua attività da libero professionista. Da autonomo, si erano allineati tutti gli elementi che gli davano soddisfazione: l’adrenalina della medicina d’urgenza, l’esperienza nel suo campo d’elezione e, non da ultimo, la possibilità di viaggiare – una media di 60 000 chilometri l’anno. Verona, Vicenza, la riviera romagnola... addirittura quindici giorni di navigazione nel mare Adriatico, a bordo di una nave equipaggiata con un prototipo sperimentale del Politecnico di Torino, progettato per ricavare energia dal moto ondoso. La decisione di mettere su famiglia lo porta a rivedere le sue priorità, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra vita e lavoro. Di qui la scelta di partecipare a un bando di selezione per infermieri da destinare al reparto Emergenza-Urgenza, indetto dalla stessa USL per cui aveva già lavorato in passato. Ciò che accadrà all’indomani dell’assegnazione – prima presso il pronto soccorso di un piccolo ospedale della zona (2020-2022), poi in una seconda struttura, più grande, riaperta per motivi politici dopo la chiusura durante la pandemia (2022-2023) – rappresenterà uno snodo decisivo nella vita di Pasquale. E, al di là della sua vicenda personale, offre spunti significativi sulla gestione della sanità pubblica, ispirati – come lui stesso sintetizza con lucidità – al «solito gioco delle tre carte, imposto dalla deleteria indissolubilità del legame tra amministrazioni regionali e direzioni generali ospedaliere».
⁎
Ancor prima della diffusione delle piattaforme di intrattenimento on demand, le serie TV – soprattutto quelle nordamericane – riscuotevano già un grande successo di pubblico. Tra le più popolari negli anni dell’adolescenza di Pasquale (lo ricordo bene, dato che siamo più o meno coetanei), c’era E.R. – Medici in prima linea, un medical drama ambientato nel pronto soccorso di un grande ospedale della contea di Chicago. Come più tardi Grey’s Anatomy, Dr. House e molte altre, contribuì a diffondere un’immagine idealizzata della vita di corsia, trasmettendo al pubblico l’idea di un continuo alternarsi di casi straordinari e storie avvincenti. La realtà, però, è decisamente più prosaica: non di rado, il lavoro di chi si occupa di medicina d’urgenza consiste in notti trascorse ad attendere una chiamata, oppure nel gestire comportamenti aggressivi da parte di persone con dipendenze, che frequentemente si rifugiano in pronto soccorso in cerca di un riparo per la notte. Il fatto stesso che non esistano soluzioni alternative adeguate per supportare questa particolare tipologia di utenza meriterebbe un’attenta riflessione.
Ciò detto, la situazione conferma ancora una volta che i pronto soccorso sono il “canarino nella miniera” dello stato di salute complessivo dei servizi di assistenza territoriale. Non è affatto vero, comunque, che la professionalità si misuri in base al numero di codici rossi gestiti. Anzi, direi piuttosto il contrario: spesso, in contesti non segnati da calamità o conflitti, l’eroismo si manifesta nella ripetizione silenziosa di tanti piccoli – e talvolta meno piccoli – atti virtuosi. Tra questi, inserirei senz’altro la capacità di sopportare condizioni di lavoro altamente stressanti, senza il supporto di un reparto strutturato. Pasquale mi fa un elenco, ordinato per grado crescente di pericolosità: al livello base c’è la sala d’aspetto del pronto soccorso; segue un livello intermedio, rappresentato dall’automedica o dall’ambulanza; infine, il massimo livello di esposizione: la strada o l’abitazione del paziente. Il criterio di assegnazione su questa “scala di vulnerabilità” è dato dalla distanza dalla zona di comfort, definita da due elementi: la superiorità numerica degli operatori sull’utenza e la possibilità, tutt’altro che remota, di incorrere in minacce all’incolumità personale. «Ogni intervento in esterna è una sorpresa. Se c’è bisogno di richiedere il supporto delle forze di pubblica sicurezza, lo si scopre solo una volta arrivati sul posto. Se sei per strada e ci riesci, puoi chiuderti in auto. Se invece ti trovi all’interno di una casa che non conosci, allora lì te la devi giocare. E puoi solo sperare che quel giorno ti vada bene.» Prendo in prestito un’altra sua espressione: «Oggi il lavoro da libero professionista mi consente di spendermi come voglio col paziente. Di stare dentro al processo della cura, accompagnandolo in ogni fase, compresi gli ordini per il riassortimento delle scorte. Ne trae vantaggio il paziente e, di riflesso, ne sono soddisfatto io». Se pure estrapolate da un contesto diverso, le sue parole condensano perfettamente il senso profondo di una professione in cui il contatto umano rappresenta una base imprescindibile. Si tratta in buona percentuale di un contatto fisico ravvicinato: gesti, manovre, somministrazioni che presuppongono la fiducia del paziente, un certo suo abbandonarsi: af-fidarsi e con-fidare. Tuttavia, proprio a causa della prossimità fisica, specialmente in spazi ristretti o sovraffollati, il contatto può facilmente degenerare e tramutarsi nel suo contrario: lo scontro e la violenza. «Personalmente, probabilmente grazie alla mia stazza fisica, finché ho lavorato in pronto soccorso non ho mai subito aggressioni. Sono stato testimone di un pugno sferrato a un collega dal parente di un paziente in sala d’aspetto, preso dalla frenesia di sfogarsi col primo malcapitato per il protrarsi dei tempi d’attesa. Si lavora costantemente sotto pressione, tanto che la maggior parte dei miei ex colleghi è in perenne affanno. Quasi in ogni turno mi toccava ripetere all’utenza: “Chi aspetta è perché può aspettare. Se vedete entrare qualcuno ed essere portato direttamente oltre la porta divisoria vuol dire che ha la precedenza assoluta, perché non può aspettare”. Non tornerei mai e poi mai in ospedale. Oramai ho fatto le mie scelte, ma non nego che l’emergenza-urgenza mi manchi molto.»
Tutto si consuma nell’arco di poco più di un anno: da un singolo episodio – peraltro di modesta entità – prende avvio una catena di eventi. Come una valanga che, rotolando a valle, s’ingrossa mano a mano, si giunge ad un processo, che si conclude con un’assoluzione. Solo in apparenza un lieto fine: a rigore, sarebbe più corretto definirla una classica “vittoria di Pirro”. Sorprendentemente, dato il luogo in cui si svolge, l’esposizione dei fatti richiede molto meno tempo del racconto delle sue conseguenze. Accade che un’anziana affetta da demenza senile, già nota agli operatori, venga trasportata in pronto soccorso per uno stato di agitazione non più gestibile dalla badante che abitualmente la segue. Il medico chirurgo di turno, coadiuvato da Pasquale, è impegnato in quel momento in una procedura ben più delicata su un’altra paziente. Tuttavia, il vociare proveniente dall’accettazione spinge Pasquale a intervenire. D’accordo con il medico, e dopo aver constatato che la situazione può essere gestita in tranquillità, somministra alla donna una prima terapia. La paziente si calma e tutto sembra rientrare. L’arrivo della badante però riaccende la tensione: a quel punto, a gridare sono in due. Nel tentativo di placare gli animi, interviene anche il medico che, mentre Pasquale si occupa dell’anziana, prova a spiegarsi con la badante, convinta che all’anziana non siano state date le dovute attenzioni. Ma ogni tentativo si rivela vano, al che il medico, prendendola per i polsi, la invita garbatamente a sedersi e ad ascoltare. Nel giro di poco, la situazione torna alla calma. Tuttavia, a una settimana di distanza, la badante sporge denuncia contro il medico per lesioni, minacce e violenza privata. L’azienda ospedaliera, a sua volta, apre un procedimento disciplinare e – dopo aver ascoltato anche i testimoni presenti, tra cui naturalmente Pasquale – decide di applicare una trattenuta sulla busta paga del chirurgo, accompagnata da una nota scritta di demerito. Il medico, indignato soprattutto per la macchia inferta alla sua reputazione, si rivolge al tribunale competente. Constata l’impossibilità di una conciliazione tra le parti, il giudice ascolta tutti i testimoni per due volte e dà ragione al querelante. La sentenza condanna infatti l’azienda al pagamento delle spese legali, impone la restituzione dell’importo trattenuto, la cancellazione della nota di demerito e, previo benestare del medico stesso – nel frattempo dimessosi –, dispone il suo reintegro in organico. A quindici giorni dalla conclusione del processo, questi rientra in servizio e Pasquale sostiene la prova orale di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso la USL, che anche noi abbiamo ormai imparato a conoscere.
1 Si veda il 7o Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, in particolare il Capitolo 7, Il personale sanitario, pp. 124-128. Il rapporto è consultabile gratuitamente (previa registrazione) sul sito della Fondazione GIMBE: https://salviamo-ssn.it/attivita/rapporto/7-rapporto-gimbe.it-IT.html.
Valentina Brini Emiliana, classe 1991. Laureata in farmacia e nutrizione, sceglie di allontanarsi dal mondo sanitario dopo averne conosciuto da vicino le crepe e il logorio. Da sempre spinta da un bisogno di autenticità, ha trovato nella musica e nella fotografia i suoi linguaggi più veri. Viaggiatrice inquieta, attraversa luoghi e volti alla ricerca di qualcosa di vero. Cerca ancora dei buoni obiettivi fotografici e non.Annelise D'Egidio Origini lucane, studi in filosofia. Prima della scuola Jack London, esperienze lavorative tra loro eterogenee, ma accomunate dalla medesima precarietà contrattuale. In mezzo: viaggi, scoperte, incontri e trasferimenti. In sottofondo, tanta musica e molti podcast. Circondata da immancabili pile di libri, tuttora alla ricerca di un centro di gravità permanente.
Libri EllePì - Appunti di viaggio sul senso del lavoro
Il volume Appunti di viaggio sul senso del lavoro è un mosaico di riflessioni collettive che nasce dall’esperienza quindicennale della Fondazione Lavoroperlapersona ETS. Il libro raccoglie una serie di contributi pubblicati originariamente sul settimanale Voce della Vallesina e si configura come un itinerario di pensiero e testimonianza che intreccia economia, etica, cultura e comunità.
Fin dalle prime pagine, Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione, introduce il progetto come parte di un percorso più ampio di educazione e ricerca volto a riscoprire il significato profondo del lavoro come atto sociale e non solo economico. Il lavoro viene descritto come spazio di incontro, di dignità e di generatività: un ambito in cui l’uomo realizza sé stesso contribuendo al bene comune.
Le cinque sezioni del volume — Diversità e inclusione, Generatività, Generazioni ed età, Responsabilità sociale e Senso del lavoro — costruiscono una narrazione corale in cui il lavoro viene raccontato attraverso molteplici sguardi: quello della cura e dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia, ma anche del desiderio, della creatività e della felicità. Ogni capitolo affronta un nodo cruciale della contemporaneità: la mancanza di lavoro come assenza di dignità, il valore invisibile del lavoro di cura, la costruzione della pace attraverso l’impegno quotidiano, la sfida dell’inclusione, la responsabilità delle imprese, la sicurezza e la povertà lavorativa, fino a interrogarsi su come il lavoro possa diventare ancora un’esperienza di senso e di libertà.
La scrittura a più voci — sobria, essenziale, eppure densa di pensiero — rende il libro un vero laboratorio di umanità: ogni contributo riflette un impegno educativo e culturale volto a “coltivare l’umano nell’economia”. L’opera non si limita a una riflessione teorica, ma propone un dialogo vivo con il territorio e con le persone, restituendo la concretezza di un impegno civile e comunitario.
In un’epoca in cui il lavoro è spesso ridotto a mero strumento produttivo o a variabile economica, Appunti di viaggio sul senso del lavoro invita a recuperare la dimensione etica, relazionale e spirituale del lavoro come luogo di costruzione di sé e del mondo. È, in definitiva, un libro che parla di responsabilità e di speranza, e che offre alla storia della Fondazione un tassello prezioso nella sua missione di diffondere una cultura del lavoro capace di mettere sempre la persona al centro.
Clicca sull'immagine per scaricare il volume!
#Blog EllePì - Il lavoro? Un gioco da ragazzi!
Sabato 25 ottobre presso il suggestivo Palazzo Luminari di Rosora si è svolto un evento dal titolo “Un gioco… da ragazzi!”, pensato per mescolare divertimento e riflessione attorno al tema del lavoro. Insieme a Sonia Palermo - pedagogista del lavoro - e Chiara Pallotta - educatrice della Fondazione - i ragazzi e le ragazze del territorio di Rosora hanno esplorato il senso del lavoro attraverso un percorso ludico-educativo che ha preso spunto da personaggi illustri della scienza, della letteratura, dell’economia e della filosofia. Il gioco è nato dalla volontà di trasformare in una dinamica avventura intergenerazionale la pubblicazione “Appunti di viaggio sul senso del lavoro”.
L’evento è stato vissuto come momento di crescita, scoperta e partecipazione: la dimensione del gioco, accostata alla riflessione sulle vocazioni e sul senso del lavoro, ha permesso ai partecipanti di confrontarsi attivamente con idee, valori e storie che – al di là del “fare” – parlano di “essere” e “essere-con”. Tra i valori richiamati spiccano il rispetto dell’unicità della persona, la dignità del lavoro come espressione dell’essere umano, la diversità come ricchezza da valorizzare, la solidarietà e l’imprenditività come ingredienti di una cittadinanza accogliente, aperta e creativa. È proprio in questo spirito che l’iniziativa “Un gioco… da ragazzi!” ha preso forma: non solo un momento ludico-ricreativo, ma un’occasione per coltivare una cultura del lavoro che rimettere la persona – e non solo il profitto o la produttività – al centro.
I ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di scoprire – giocando – come il lavoro non sia solo un “compito” da svolgere, ma un orizzonte di senso che lega passato e futuro, generazioni diverse e aspirazioni personali. Emerge chiaramente come il gioco, inteso come palestra di vita, diventi strumento educativo: attraverso la cooperazione, la condivisione, la negoziazione e il rispetto dell’altro i partecipanti sono stati invitati a sperimentare attivamente i relativi valori. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo: la loro presenza ha reso tangibile che educare al lavoro significa anche educare alle relazioni, alla responsabilità, alla libertà e alla creatività. E nella comunità di Rosora questo messaggio ha trovato terreno fertile. L’auspicio è che quanto vissuto sia solo un inizio, capace di generare ulteriori occasioni di dialogo intergenerazionale, laboratori di scoperta, e momenti in cui il lavoro diventa strumento per fiorire come persona.